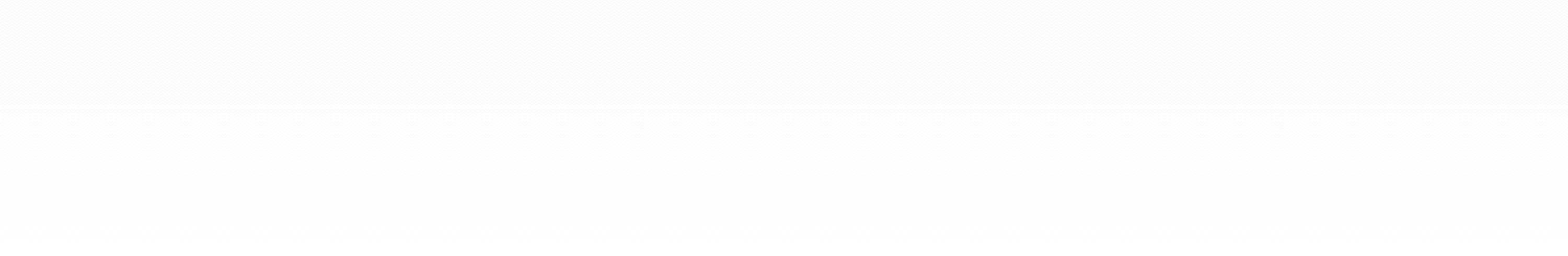24 novembre 2008
DA BABELE A GERUSALEMME:idee per costruire una città a misura d’uomo
Intervento di padre Frigerio
BABELE: PROGETTO E DELIRIO.
Oggi si parla di “qualità della vita”, di “qualità dell’abitare”, la pubblicità di una pubblicazione specialistica accosta le due “qualità” identificandole. Vorrei riflettere con voi sul senso ma anche sull’ambiguità di queste espressioni, e lo faccio risalendo a un testo antichissimo (IV° sec.a.C.) la cui sapienza può illuminarci ancora oggi. Intendo parlare del mito di Babele, che leggiamo in Gen.11,1-9, un testo breve nella sua estensione, ma sommamente ricco di indicazioni ancora capaci di provocare la nostra attenzione.
La sua collocazione nel libro della Genesi ha un ruolo di cerniera: chiude, riassumendo, l’epoca dell’opposizione dell’Adam, di Caino, di Lamech, della generazione del diluvio, quindi dei costruttori della Città/Torre, mentre con il capitolo XII apre l’epoca dell’Alleanza tra Dio e Abramo. Per il lettore del Pentateuco l’epopea di Babele riassume la storia del peccato. La chiamata di Abramo inaugurerà quella della salvezza.
Il testo non parla mai di colpa, non accenna mai a una collera divina. Jhwh si mostra curioso (viene a vedere l’opera umana) e irritato. Non disapprova, ma constata l’ambiguità dell’opera. Non è la storia di una punizione ma l’affermazione drammatica di un progetto creativo. La dispersione dell’umanità su tutta la terra è il completamento voluto dal Creatore di uno sviluppo della sua creatura: “Crescete, moltiplicatevi e percorrete la Terra” (Gen 1,28).
Il grande tema della “confusione delle lingue” ( o meglio delle “culture”) deve essere letto raccordandolo ai gesti antropologicamente fondamentali del “raccogliere”, “costruire”, “nominare” e, dunque, dell’”abitare”. Le conseguenze più essenzialmente politiche dell’impresa babelica saranno l’effetto di un processo più ampio e profondo in relazione al senso dell’umano: la volontà di affermazione di una certa idea di soggetto e dell’esito tragico a cui essa va incontro. Il dramma di Babele è il virare dall’azione primaria del raccogliere/costruire/nominare nei riflessivi raccogliersi/costruirsi/nominarsi. E’ il delirio le cui rovine sono visibili dalla Torre.
Raccogliere
I versetti d’inizio affermano la certezza che la “distinzione” è una “cosa buona” e come tale non è affatto, di per sé e ancora, “confusione”. E’ la capacità di Dio di creare esistenze del tutto autonome, in sé assolutamente positive: nel capitolo X si enumerano più di settanta nomi tra uomini e clan, esistenze di popoli e lingue diversi. La varietà, la bellezza e la stabilità costituiscono quel non segreto della sua Parola che attende la risposta consapevole e libera dell’uomo, che non può avvenire se non attraverso le diverse parole degli uomini.
“Abitare la terra “ deve essere inteso in rapporto al compito del “governare/nominare”. Da questo punto di vista l’”abitare” è sempre il destino di una fecondità umana che è il rispondere creativo e libero, creativo perché libero, e fecondità mai riducibile alla sola riproduzione.
Il racconto di ciò che avviene nella pianura di Sennaar inizia con un dato di fatto, poi c’è la narrazione dello svolgersi di una storia, di un viaggio all’interno del quale l’uomo risponde e così abita nell’esistenza a lui assegnata. Come si risponde a Babele?
“Venite”: l’uomo chiama a raccolta gli uomini. Questa raccolta è la chiamata della diversità degli uomini attorno all’unità dell’uomo: raccogliamo l’uomo attorno a se stesso. La scena è lasciata interamente all’iniziativa umana, al centro di essa si trova solo l’autonomia stessa dell’uomo. La raccolta è in verità un raccogliersi – venite, facciamoci…costruiamoci – e il prodotto della loro attività “doveva essere il vincolo che legava gli uni agli altri” [Hegel]. Questa unità però deve essere sempre riscoperta e ricostruita, riguadagnata e scelta dal fondo di ogni diversità. “Venite” significa “preparatevi” tutti insieme a lavorare, a deliberare, a portare pesi: uomini preparatevi all’uomo!
Gli uomini si chiamano a raccolta e iniziano a parlare tra loro di sé, e in questo parlarsi delimitano uno spazio proprio, il luogo della propria intimità, in grado di resistere all’invadenza dell’esterno.
Costruire
La raccolta attorno a sé e in sé che sai celebra a Babele avviene attraverso la costruzione di qualcosa fuori di sé, attorno alla Torre, segno/sogno di un’identità raggiunta e realizzata. La costruzione della Torre appare senza dubbio come un effetto della raccolta, ma, come sottolinea Hegel, ”è nel medesimo tempo simbolica, in quanto accenna solamente al vincolo da lei costituito”.
Raccogliere vuol dire costruire, ma costruire vuol dire soprattutto istituire, manifestare un’identità. In questa realizzazione è in gioco il suo stesso realizzarsi come uomo.
“Costruire significa originariamente abitare…Io abito, tu abiti. Il modo in cui tu sei e io sono, il modo in cui noi uomini siamo sulla terra è l’abitare. Essere uomo significa: essere sulla terra come mortale, e cioè abitare….Abitare, essere posti nella pace, vuol dire: rimanere nella protezione entro ciò che ci è parente e che ha cura di ogni cosa nella sua essenza” e ancora “sulla terra significa anche “sotto il cielo”. Entrambi significano insieme “rimanere davanti ai divini” [Haidegger]. Dunque l’abitare dei mortali è accoglienza del cielo e attesa del divino. E la Torre, una ziqqurat (da zaqura = costruire in altezza) aveva la funzione simbolica di collegare la terra e il cielo, onde permettere a re e sacerdoti di salire e incontrare le divinità che vi si assidevano (toccare il cielo).
Il lavoro a Babele deve essere inteso in due modi diversi. Da una parte appartiene allo “sforzo collettivo che mira a sgombrare un angolo della terra dalla “selva mitica”, lavoro di dissodamento e di costruzione, dunque di civiltà che è proprio dell’uomo e nel quale egli esprime ciò che gli è proprio. Dall’altra parte, contro ogni ingenua esaltazione dell’operare umano, si può intravedere in una certa trasformazione della materia (“il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento”) anche un pericoloso atto di presunzione, di ingenua megalomania.
Da questo punto di vista il brano di Genesi è uno dei testi biblici più espliciti sull’irriducibile distanza che una tradizione nomade intende prendere e mantenere nei confronti di una civiltà urbana che ai suoi occhi rischia insistentemente di chiudersi in una pericolosa e violenta autarchia.
Il testo dice:”Facciamoci mattoni, costruiamoci una città e una torre, facciamoci un nome in modo da non disperderci su tutta la terra”. In questo luogo, pertanto, si concentra una forte aspettativa e si coagula un enorme investimento di senso: la Torre idealizzata, compensa la mancanza di identità, di unità, di stabilità, infine di un nome, del proprio nome. Al di là del conflitto per il primato tra filosofia e teologia, è dunque l’architettura e le tecniche di costruzione a rappresentare il vero compito del sapere di Babele. Così inteso, l’alzarsi della Torre deve essere letto come l’ergersi del biblico “idolo”, che è sempre “una parte” che, innalzata e mirata come il “Tutto”, dà soddisfazione al vagare dei diversi sguardi.
Questa “estasi” non è il sintomo patologico di una coscienza disturbata, ma la rigorosa conseguenza del processo di identificazione/idealizzazione che sempre è alla base dello sguardo idolatrino. La costruzione della torre, che diventa la Torre, si trova a esercitare quella forza d’attrazione che fa di “un qualcosa” il “Tutto”: l’impresa prende la mano al suo artefice e diventa il luogo stesso dell’affermazione della magia dell’automatismo e del riproporsi della logica alla base dell’antica tentazione, sempre la stessa, l’unica: si mangi il frutto del bene e del male e subito, magicamente, si diventerà come il Signore Iddio. Di fronte al fascino della proposta diabolica e all’attrazione della costruzione idolatrica, di fronte a questa opportunità che rende inutile l’opera della singola responsabilità e assorbe il tempo della storia nell’istante di un atto meccanico, non è assurdo che con un certo entusiasmo, ci si sia consegnati a un lavoro frenetico, automatico, regolato da quel regime che Adorno ha chiamato “l’organizzazione totale” (vedi il genocidio moderno che è elemento di ingegneria sociale mirante a realizzare un ordine sociale conforme al progetto della società perfetta).
Che tipo di risposta è dunque quella che risuona a Babele, che tipo di legame e di ponte, di quale natura è l’abitare/pensare che si afferma?
“Costruiamoci una città e una torre…”: si stabilisce un nesso essenziale tra l’orizzontalità della costruzione della città, il rapporto tra i mortali, e la verticalizzazione della costruzione della Torre, il rapporto tra la terra e il cielo. Il testo non risponde ai nostri interrogativi, ma una risposta deve essere cercata nel tipo di intreccio che lega tra loro questa orizzontalità e questa verticalità.
All’interno dell’orizzontalità tra i mortali, che precede la verticalità, c’è un’opera di edificazione che procede senza sosta, meccanicamente, in un regime di “organizzazione totale”, con una “disattenzione” per il singolo che non deve essere considerata come una mancanza - superficialità o, peggio, malvagità – ma più profondamente come attenzione assoluta, esigita dal “tutto”, come sempre accade all’interno della prospettiva idolatrica. Von Balthasar descrive un ipotetico mondo nel quale il progetto di una conoscenza assoluta porta inesorabilmente a trascurare e infine a negare il valore stesso dell’esistenza del singolo: “non ci sarebbe più l’essenziale mistero che circonda ogni esistente che è per sé. Il processo della conoscenza proietterebbe una fredda luce crudele senza ombra in tutti gli angoli. L’essere senza mistero sarebbe come prostituito.”
Dunque in quel luogo che chiamiamo Babele è avvenuto l’inarrestabile virare dell’orizzontalità nella verticalità. Si è affermato che la città viene prima della Torre, ma in verità quest’ultima è già in gestazione all’interno della prima. All’interno del senso dell’abitare/pensare, di cui l’impresa babelica è espressione, c’è l’inevitabilità di questa virata. Ciò attorno a cui il “venite” raccoglie, è l’opera di edificazione della Torre, ma ora bisogna aggiungere che è proprio tale raccolta a esigere e a imporre che la verticalizzazione dello spazio sia precondizione della raccolta stessa. La presa di distanza dall’invasione della selva mitica che si stabilisce in questa piana di Sennaar sembra dunque aver prodotto da una parte l’identificazione intesa come una costruzione pura opera dell’uomo, frutto della sua autonoma capacità di progettare e realizzare, e dall’altra parte sembra avere anche imposto la verticalità come l’unica dimensione in grado di garantire alla costruzione stessa la sua forza di attrazione e di dominio su tutto e su tutti.
Il senso del costruire e del dar-forma in Gen 11, 1-9 è questo: non si descrive la costruzione della città né quella della torre, ma si narra della costruzione della città in quanto Torre. Babele è un nome proprio, è il nome della città – spazio orizzontale della convivenza tra gli uomini, luogo dell’abitare – in quanto Torre.
Nominare
Il gesto del nominare abbraccia e attraversa tutto il brano, al cuore del racconto. E’ nel nominare che si esalta il rispondere dell’uomo di cui Babele è una delle scene. Vivere comporta il nominare. “…facciamoci un nome”: la verticalità della Torre è l’immagine dell’assoluta verticalizzazione che consiste nel volersi fare il proprio nome. In Gn 2,19 l’Adam è sollecitato a dare il nome a ogni vivente. Così inteso il nominare si configura con il gesto dell’Adam che più intimamente partecipa all’impresa della creazione, e in quanto tale rappresenta una delle espressioni più alte del suo stesso essere “immagine e somiglianza” del Creatore. Dunque cogliamo il carattere non immediatamente negativo dell’impresa narrata dal testo biblico. Eppure, ancora una volta, questa legittima rivendicazione si rivela essere una trappola e il luogo delle più pericolose tentazioni.
“Farsi un nome significa rivendicare apertamente il proprio diritto all’esistenza … entrare nella Storia … costruiamoci un nome come noi costruiremo la Torre. In ogni modo l’uomo tenta una desacralizzazione del nome e procede ad auto-nominazione che lo condurrà, con una conseguenza quasi inevitabile, alla sottomissione a un tiranno e alla perdita della ragione” (Zumthor).
E’ possibile individuare i veri e propri effetti del cedimento alla “tentazione idolatrica”.
Il primo effetto: il racconto conosce e mette in scena solo personaggi collettivi e privi di nome proprio. Nel corso dei primi dieci capitoli della Genesi ogni attore porta un nome “proprio”, ci sono pagine genealogiche prima e dopo questo racconto. Con la folla anonima di Babele il contrasto è significativo. Qui “dopo Adamo, Eva, Abele, Caino, Enoc, Noè …spunta il noi che non è la somma di molti io personalizzati, è un “io fittizio”, la prima non-persona del plurale, folla indifferenziata, preda offerta al primo tiranno che venga (cfr.Zumthor).
Il secondo effetto: in Gn 2,19 il Creatore affida all’Adam il compito di nominare tutti i viventi, ma non si dice nulla dell’uomo stesso. Il Creatore avoca a sé il diritto di chiamare l’uomo e di chiamarlo proprio per nome (cfr.Ap 2,17).
La babelica “attività macchinale” distrae dal dramma della storia verticale-orizzontale dell’Alleanza, facendo così cedere alla tentazione idolatrica di “farsi un nome”.
Inebriato dal suo stesso potere di nominare/dominare (deformazione del governare), l’uomo decide di darsi il nome e così dominarsi. Per tentare di fare questo, a Babele ci si concentra sulla sola costruzione della Torre e si trascura ogni uomo, non si riesce a far di meglio che trasferire su di sé lo stesso tipo di nome che si dà alle cose. A Babele, infatti, si celebra l’agire, ma non c’è traccia del rispondere: ognuno fa quello che deve, autonomamente/meccanicamente, ma per far questo non trova più il tempo e l’attenzione necessari né per intendere il risuonare del proprio nome, né per rispondere alla chiamata che proviene dall’altro. Nella piana di Sennaar l’identità dell’uomo si confonde con quella del mattone. Non appena qui si comincia a nominare, ciò che risuona è sempre e solo il nome collettivo, un impersonale “uomini”.
Discendere e confondere
Il Santo scende, guarda e interrompe l’impresa: Nessuno condanna nessuno, anche se l’impresa viene interrotta non essendo la risposta giusta, essendosi l’uomo confuso e quindi avendo imboccato la strada sbagliata.
Nella piana di Sennaar c’è il segno della superbia della creatura che osa minare il primato stesso del Creatore, ma soprattutto ne va sempre della dignità dell’uomo, del primato stesso della singolarità di ogni uomo.
“Scendere a vedere”: severa ironia dell’autore biblico con la quale smaschera l’assurda pretesa. Al “suvvia, costruiamoci” degli uomini corrisponde il “suvvia, scendiamo” di Dio (von Rad). E’ sempre l’uomo che tenta, spera, desidera, a volte persino delira di salire, mentre è sempre il Dio biblico che discende, che si abbassa e lo fa fino alla kenosis di se stesso (Fil 2).
Qui Dio scende e vede e diffonde la confusione tra i costruttori interrompendo l’impresa, cioè manifestando il suo disappunto e prendendo con fermezza le distanze dal modo di abitare, di essere, di cui la Torre è espressione: non ne condivide la pretesa omologante.
Rinviare
Ciò che Dio non condivide nella piana di Sennaar è dunque l’attacco alla dignità dell’uomo, alla sua “qualità di vita”. Nella Bibbia ogni qualvolta Dio interviene è sempre l’uomo a essere oggetto della sua preoccupazione e della sua cura e di conseguenza la sua Parola indica una strada per la verità e la pienezza di colui al quale si rivolge, e allora la “confusione” diventa l’occasione per aprire una nuova prospettiva. Scrive Heschel: “La Bibbia è un’antropologia di Dio piuttosto che una teologia dell’uomo”! Confondendo l’idea babelica di unità omologante, Dio riconferma il nesso essenziale che lega l’ordine della Creazione a quello della differenza e dell’unicità, dell’unicità delle differenze. Lo schalom è appunto l’armonia delle differenze e perciò compito dell’uomo sarebbe quello di “aderire sinfonicamente a questa unità divina e di dare il suo assenso a questa crescente unità. Non sono previsti altri spettatori all’infuori di coloro che suonano” (von Balthazar).
All’unicità della Parola non corrisponde, dunque, l’unicità della lingua, ma la molteplicità comunionale delle parole. A Babele si è voluto minare la Parola con una lingua, si è confusa la Parola con la lingua, ed è tale confusione che l’intervento divino viene a confondere, riaffermando il legame essenziale, creaturale, tra l’unicità della Parola e la molteplicità unica delle parole.
Osserva Panikkar: “Non esiste prospettiva globale. E’ una contraddizione di termini. Nemmeno Dio, dice il Talmud, ha una prospettiva globale. Non c’è lingua universale. Le lingue sono parlate e si forgiano con il dialogo fra gli uomini. Non si può dialogare con tutti, anche se i mass-media riuscissero a indottrinarci, noi non potremmo rispondere sul senso vissuto del linguaggio. Una lingua che non sia anche una mia creazione non è la mia lingua, non è una lingua umana. Forse uno degli ultimi bastioni della mentalità colonialista consiste nel credere alle grandi lingue dell’umanità, mentre il linguaggio reale è sempre dialogico, quindi è un dialetto”.
Scrive Zumthor: “la storia di Babele non si riferisce tanto alla diversità delle lingue, quanto alla comunicazione tra gli uomini, fondamento della loro esistenza sociale e di ogni morale comune.”
“Comunicare” non è separabile dall’”Abitare” e quindi dal “Pensare”: la confusione e la dispersione non sono una condanna all’incomunicabilità ma una decisa sollecitazione al comunicare stesso, un modo di risvegliare gli uomini dal loro sonno magico e dalla frenesia macchinale che li accompagna, per costringerli a pensare. La risposta più diretta a Gn 11 è Atti 2,1-11 relativo alla Pentecoste il cui senso più profondo consiste nel definitivo superamento della confusione babelica e nella conseguente riguadagnata unità armonica tra i popoli diversi. Non più “noi” o “uomini” anonimi, ma ciascuno secondo il proprio accento, il proprio dialetto, la propria storia, in una parola: secondo il proprio nome.
La consegna
A Sennaar l’atto del costruire e del dare forma, così significante per l’uomo, tende inesorabilmente a esaurirsi in “una” costruzione che alla fine viene identificata con “la” risposta stessa di cui si andava alla ricerca. Quella Torre viene pensata e vissuta come “il tutto”. In effetti nell’erigere la Torre è come se il soggetto non riuscisse a mantenere la posizione di soggetto e cadesse il primato alla sua grande costruzione. Ecco in cosa consiste il radicale potere della magia: essa trasforma sempre un significante nel significato.
Da questo punto di vista l’insistenza sulla Torre, sulla costruzione della Torre, con l’inevitabile frenesia che essa fomenta, e nella quale sembra realizzarsi, non è tanto o solo un atto di orgoglio, quanto piuttosto il sintomo della rovina del soggetto. E’ il soggetto stesso che abdica di fronte alla sua posizione decidendo di scomparire nell’impresa.
Inoltre non ci sono dubbi che a Sennaar sia stato esercitato il potere, e ciò non sorprende affatto, dato che esso è sempre necessario per dar-forma, per meglio organizzare il lavoro. Ciò che sorprende è che se il potere non viene certamente esercitato da Dio, che infatti decide di intervenire proprio per interromperlo, parimenti esso non è neppure esercitato da un uomo o da un gruppo di uomini su tutti gli altri (Gn 11,6). A Babele il potere è quello esercitato dall’incantamento, dalla fascinazione di un lavoro, trasformato in attività macchinale: a dispetto dell’indicazione divina, non è più l’uomo a nominare/governare, ma è la Torre.
Lacan osserva: “Qual’è il proclama di Alessandro all’arrivo a Persepoli come pure di Hitler a Parigi?…. Continuate a lavorare. Il lavoro non si fermi. Che vuol dire: Beninteso questa non è in alcun modo un’occasione per manifestare un minimo desiderio. La morale del potere è: Per i desideri ripassate. Che aspettino.”
Nel racconto babelico si riconosce la scena primaria all’interno della quale in modo esplicito la posizione del potere si rivela semplicemente per quella che è: ora si lavori, al desiderio si pensi poi.
Emerge a questo livello quello che è senza dubbio uno degli aspetti più profondi del racconto: qui Dio non c’entra affatto, e quando decide di entrarci lo fa proprio perché il fatto si è trasformato in misfatto, al di là delle stesse intenzione degli uomini. E perché questo dominio si produca non sono necessari né il Potere né la malvagità di qualcuno, ma è sufficiente, magari per realizzare un’impresa grandiosa, dimenticarsi di sé, del proprio desiderio e di quello dell’altro e abbandonarsi a quell’attività macchinale a cui compete l’assoluta regolarità, la puntuale irriflessa obbedienza, l’acquisizione una volta per tutte di un determinato modo di vivere, il riempimento del tempo, anzi una certa costrizione educativa all’impersonalità, all’oblio di sé.
L’antico grido risuona nuovamente: venite! Raccogliamoci, non disperdiamoci! Anche il senso dell’invito è lo stesso: ridurre il mondo alla ragione, costruire un’esistenza perfetta e autosufficiente, contrabbandandola per “qualità della vita”, con un diverso contenuto dell’appello: non più forza, lavorate; continuate a lavorare; il lavoro non si fermi, ma piuttosto forza, consumate, continuate a consumare.
In realtà, come accadde anche allora, al di là delle stesse intenzioni dei costruttori, è solo durante la costruzione della Torre che l’impresa rivela inesorabilmente il suo volto. E gli effetti del progetto non si sono fatti attendere: anche oggi ciò che si presenta come la ricerca dell’unica lingua appare sempre più come l’universalizzazione del dialetto più potente; analogamente non si fa altro che parlare dell’uomo e del suo bene, ma sempre più emerge con chiarezza come non si parli affatto nel suo nome; l’esperienza del tempo, ancora una volta, assume sempre più quella forma d’attività brulicante e frenetica finalizzata al raggiungimento di un futuro che per il momento esige solo sacrifici: non c’è alcun “centuplo quaggiù”, non se ne ha il tempo.
Inoltre, la nuova parola d’ordine “Consumate!” sembra che non riesca a evitare l’antica legge del dominio e dell’imposizione, l’antico sogno di un’organizzazione che, per poter essere perfetta, deve essere necessariamente assoluta e senza defezioni.
Non c’è alternativa: bisogna salvaguardare la pace, e per far questo è necessario ridurre il mondo alla ragione, imporre la democrazia, garantire la sicurezza e soprattutto sviluppare l’economia. Ora – la voce più forte che circola in quella piana di Sennaar sono le superpotenze occidentali – per aiutare l’economia bisogna incrementare i consumi: non si ha il tempo per pensare a ciò che si dice, non ci si vergogna più di ciò che si dice e ancora una volta, inevitabilmente, si confondono le cause con gli effetti. Con parole diverse il potere conserva sempre la stessa posizione: “Consumate,dunque! Per il desiderio, ripassate.”
In termini biblici il compito è sempre lo stesso: abitate, percorrete la terra, governate/nominate, rispondete al nome e chiamate per nome, e nel far questo, ma soprattutto per fare questo, non cedete sul desiderio. Anche la parola che il testo relativo a Babele instancabilmente consegna è sempre la stessa; con assoluta fermezza, con la massima discrezione, senza alcuna condanna, evitando ogni maledizione dell’uomo e della sua opera, scendendo fino in terra, essa non si stanca di ripetere: vigilate, non in questo modo, non così!
Questa parola è scritta e anch’essa continua ad alzarsi e a risuonare: chi vorrà ascoltarla? (Silvano Petrosino).